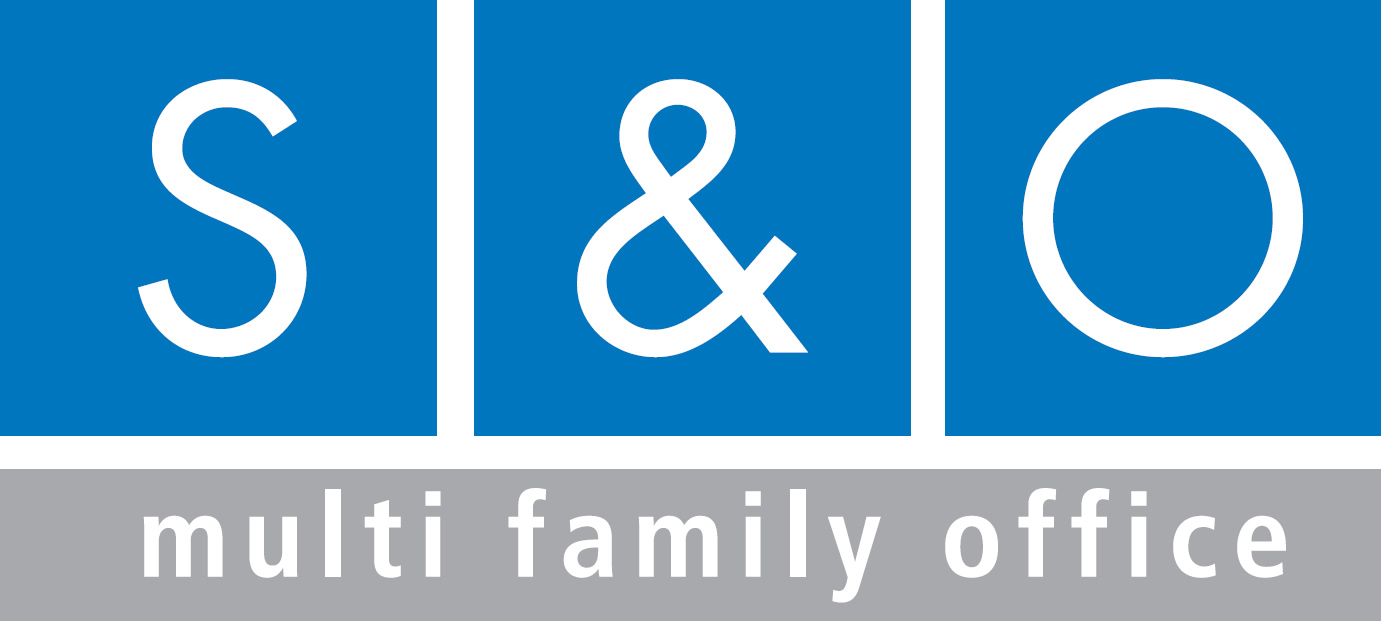L’inflazione Usa sale al 6,2%, ai massimi da oltre 30 anni
Ai massimi da oltre trent’anni. L’inflazione degli Stati Uniti, misurata dall’indice Cpi dei prezzi urbani, è salita a ottobre al 6,2%, dal 5,4% di settembre. È il livello più alto mai raggiunto da novembre 1990. L’inflazione core, che esclude alimentari ed energia, è salita al 4,6%, un livello mai toccato dall’agosto 1991, dal 4% di ottobre. Piuttosto elevati anche i rialzi mensili, in questa fase più rilevanti del solito (i dati di ottobre 2020 erano evidentemente falsati dall’epidemia): rispettivamente +0,9% e +0,6%.
Sono numeri che suscitano qualche inquietudine. Anche perché interrompono quello che sembrava l’inizio di una tendenza al raffreddamento del costo della vita. L’inflazione core era già salita al 4,5% a luglio, ma era poi calata al 4% ad agosto. Il forte rialzo di ottobre sembra aprire uno scenario diverso. I mercati hanno reagito con moderazione, ma in direzioni che segnalano come gli investitori stiano ora immaginando un rialzo dei tassi più vicino nel tempo: in seguito alla pubblicazione dei dati è salito il cambio effettivo del dollaro, sono leggermente calate le azioni, mentre i rendimenti del decennale sono lievemente saliti.
La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha cercato di rassicurare i mercati: negli anni 70, quelli dell’iperinflazione, ha detto, «le persone pensavano che i decisori non l’avrebbero fermata e le aspettative di inflazione si radicarono nella psiche degli americani. Tutto questo non sta accadendo, ora, e la Fed non permetterà che accada». Anche la presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly, ha cercato di prendere il controllo delle aspettative, ripetendo che l’inflazione è transitoria ed è destinata a calare alla fine della pandemia, e che sarebbe «abbastanza prematuro» sia alzare i tassi adesso sia accelerare la riduzione degli acquisti di titoli. «L’incertezza richiede da parte nostra di aspettare e osservare con attenzione» gli eventi, ha detto a Bloomberg Tv.
A preoccupare, però, non è il livello in sé della velocità dei prezzi, ma l’ampiezza dei rincari. L’idea – più volte ripetuta dalla Federal Reserve, come dalle altre banche centrali – che l’inflazione sia legata all’aumento dell’energia da una parte e alle strozzature delle catene di forniture dall’altra non trova riscontro nei dati pubblicati ieri. A differenza di quanto accade in Eurolandia, dove solo l’energia e pochi altri settori (veicoli, mobili) segnalano aumenti superiori all’obiettivo, nelle città degli Stati Uniti – su cui accende i riflettori l’indice Cpi – i prezzi di tutti i settori segnalano forti incrementi, non solo decisamente superiori al 2% ma anche incompatibili con il nuovo obiettivo della Fed, quell’inflazione “media” (sempre del 2%) che permetterebbe un’inflazione un po’ più elevata per qualche mese. Se i prezzi dell’energia sono aumentati del 30%, quelli dei veicoli nuovi sono saliti del 9,8% e quelli usati del 26,4%, e quelli dei mobili del 12%. I vestiti sono aumentati del 4,1% (meno quelli da donna), le scarpe del 5,2%, gli elettrodomestici del 6,6%, alberghi e motel del 25,5%. In flessione quasi solo i costi dei medicinali (-0,4%), delle polizze assicurative (-6,4%), dei telefoni (-15,1%), e degli smartphone (-20,7%). Nel complesso, i beni industriali (esclusa l’energia) sono rincarati dell’8,4%, i servizi del 3,2 per cento. «La tesi della Fed sulla “transitorietà” si basa sull’argomento che le recenti pressioni sui prezzi sono concentrate nelle categorie molto volatili e si annulleranno quando gli effetti del Covid sugli schemi della domanda e sulle catene delle forniture svaniranno. Ora che le pressioni dei prezzi si stanno allargando alle componenti meno volatili, quest’ argomento è più difficile da difendere», hanno spiegato in una nota Aneta Markowska e Thomas Simons della Jefferies.
Complessivamente non è quindi, a prima vista almeno, un buon segnale. Significa che i rialzi si sono diffusi un po’ dappertutto, il rincaro è generalizzato e non si può più parlare di una semplice variazione dei prezzi relativi. Le imprese riescono evidentemente a trasferire ai consumatori i loro maggiori costi, grazie probabilmente anche ai forti risparmi straordinari realizzati durante i mesi più duri della pandemia da una parte importante di americani. È evidente però che rincari così forti comprimono il potere d’acquisto delle famiglie, riducono la domanda e spingono in alto le rivendicazioni salariali. Negli Usa il potere dei sindacati è meno forte rispetto all’Europa, ma le imprese hanno comunque – e da tempo – difficoltà a trovare lavoratori: c’è la possibilità quindi che aumentino i salari e il rischio che questi incrementi delle retribuzioni si scarichino di nuovo sui prezzi. A quel punto la Fed sarebbe costretta a intervenire, con il rischio però di “trovarsi dietro la curva”, in ritardo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articolo tratto da “Il Sole 24 Ore” del 11/11/2021